Il bombardamento di Potenza (8-9 Settembre 1943): il racconto inedito di un protagonista
di Antonio Rubino
 |
| Aereo delle forze alleate durante la II Guerra Mondiale Foto tratte da: Potenza d'Epoca - "I video e le foto piu' antiche" |
Il
25 Luglio del 1943 Mussolini era stato deposto. Vittorio Emanuele III aveva
nominato Badoglio capo del Governo. Il 3 settembre 1943 veniva siglato,
segretamente, l’Armistizio di Cassibile.
Cinque giorni dopo, alle 19.45, gli
italiani sono incollati con le orecchie alla radio, Badoglio legge il suo
proclama rendendo pubblico l’armistizio. Gli Italiani cessano ogni ostilità
contro gli anglo-americani. Un proclama poco esplicito ma che, nel disorientamento generale, viene accolto con speranza [1].
Beppe
Fenoglio, in Primavera di bellezza, sintetizza magistralmente quei mesi in
pochissime frasi:
« E poi nemmeno l’ordine hanno saputo darci. Di ordini ne è arrivato un fottio, ma uno diverso dall’altro, o contrario. Resistere ai tedeschi - non sparare sui tedeschi - non lasciarsi disarmare dai tedeschi - uccidere i tedeschi - autodisarmarsi - non cedere le armi» [2]
In
quei giorni convulsi, mentre l’VIII armata si dilegua, la città di Potenza viene
bombardata dagli aerei alleati. La città, sconvolta, conterà circa 200 vittime.
Una
delle zone maggiormente colpite dalle bombe, fu il quartiere di Santa Maria che prende il nome dalla chiesa francescana di Santa Maria del Sepolcro [3]. dove si concentravano diversi obiettivi militari.
I
frati di Santa Maria, dopo aver appreso dell’armistizio, si trovarono tra
sorpresa e sgomento sotto il bombardamento degli aerei alleati, di quel momento
conserviamo una pagina di diario davvero molto interessante. Si tratta del racconto
di quella notte di padre Mario Brienza, a quel tempo padre guardiano del
convento.
Da
tempo mi occupo dello studio della presenza francescana in Basilicata. Un
valido “supporto” nel non agevole reperimento di fonti documentarie su questa
complessa e secolare “vicenda storica”, sono alcuni manoscritti di padre Mario
Brienza, frate Minore nato a Forenza il 17 agosto 1895 e morto il 31 ottobre
1958 nel convento di Santa Maria del Sepolcro a Potenza.
Il
convento di Santa Maria, proprio grazie all’energica opera di padre Brienza,
tornò a essere un luogo francescano negli anni ‘30 del XX secolo. Mario Brienza
fu docente di storia ecclesiastica e la sua opera di studio e trascrizione ha
salvato e tramandato importantissimi documenti della Provincia dei Frati Minori
salernitano-lucana.
Nel
consultare questi appunti, tra i quali vi sono anche interessanti e inediti
saggi di storia francescana, mi sono spesso imbattuto in cronache e diari
compilati dal frate lucano in diversi luoghi della Provincia religiosa. Alla
città di Potenza padre Mario fu particolarmente legato, alla sua storia dedicò
diversi studi, celebre quello sulla parata dei turchi [4]. Si occupò anche della
storia di tanti conventi francescani lucani, girando per archivi e biblioteche
di tutta Italia.
Con
frate Mario Brienza, la notte dell’8 settembre 1943, ci sono frate Gabriele
Ronzano, suo concittadino, e gli altri frati che vivevano nel convento di Santa
Maria contornato da obiettivi militari: la chiesa, sorprendentemente, non venne
colpita.
Tra episodi che riemergono al limite della tragedia, vi sono
particolari che strappano un sorriso, tra un sandalo perso nella notte e il suo
confratello che chiede di essere confessato mentre cadono le bombe. Padre
Mario, energico e risoluto troverà riparo prima nel rifugio antiaereo per i
militari, poi insieme ai civili. Scriverà, poi, che la Provvidenza aveva salvato l’amata chiesa potentina dai
bombardamenti, forse questa fiducia in Dio, durante il fuggi fuggi di quella
notte, fece sì che frate Mario rispondesse a frate Gabriele che non era il
tempo di chiedere l’assoluzione, perché non era ancora il tempo di morire.
Il bombardamento di Potenza
di Mario Brienza ofm
Se vi fu mai una città che ha
provato cosa sia la beffa, questa sì, fu Potenza nel giorno 8 settembre 1943.
Da qualche mese gli aerei delle
nazioni alleate vi passavano con una certa frequenza, specialmente dopo lo
sbarco in Sicilia e susseguentemente al passaggio in Calabria. Mai un colpo di
mitragliatrice e di altra arma da fuoco contro di essi. Eccezion fatta un
giorno da qualche carro armato tedesco nell’altura di Montocchio.
Poi più nulla. Potenza era davvero
la città indifesa che non seppe o non volle neppure tenere nei rispetti i
pochissimi tedeschi che vi si trovavano e quei pochi, alla spicciolata, che
risalenti dalle Calabrie passavano per questa via interna.
Fin dal giugno del 1943 si era
trasferito a Potenza il comando della Settima armata agli Ordini del Principe
Adalberto di Savoia duca di Bergamo. Gli si era trovato posto per gli uffici
del comando e per il comandante. Con attività febbrile si costruì un rifugio
coperto nella villa accanto al palazzetto del Col. Francesco Scafarelli.
Vi erano tanti ufficiali, tanti
soldati nella scuola di Artiglieria. Vi erano sedici pezzi di artiglieria, che
collocati in punti strategici, avrebbero potuto imporre ai tedeschi di
passaggio di filar diritto. Questo costituiva un pericolo e davvero un pericolo
grave per Potenza. Saperla sede di comando di armata non poteva lasciar
tranquilli gli animi. Ma, come si è detto gli apparecchi alleati non furono mai
fatti degni di reazione di armi. I pochi tedeschi di transito non diedero
molestia a nessuno che si sappia, prima dell’armistizio. Né qui, d’altronde, fu
mai lanciata alcuna bomba.
Si dovette attendere la sera
dell’armistizio.
Nel pomeriggio inoltrato del giorno
8 Settembre si cominciò, da qualcuno che aveva sentito la radio, a parlare di
Armistizio e, alle 8 di sera, si ascoltò, alla radio, il messaggio di Badoglio
alla nazione. I cuori si rallegrarono, molti fecero addirittura festa pensando
che Potenza, che era lì lì per essere travolta dall’uragano, veniva salvata
giusto in tempo. Non si supponeva nulla, neppur lontanamente, di quello che
stava per succedere.
Erano le dieci di sera. La gente in
gioia e in festa nella splendida serata settembrina godeva il fresco, parlava e
commentava l’evento, quando, improvviso fragore sconvolge ogni idea, distrugge
ogni progetto. Una bomba lanciata da un apparecchio in piena città, nella
parrocchia di S. Michele a Via Roma, getta ogni scompiglio. La città si riversa
fuori in confusione massima, specie nella zona colpita. Poi tutto ritorna a
tacere.
I commenti? Altra vendetta dei
tedeschi indignati per l’armistizio italiano. Quando si va per supposizioni,
diceva il Manzoni, si finisce per far torto anche ai barbari.
Si uscì fuori, ma poi si ritornò
dentro sospettosi e pronti a uscire nuovamente non appena il pericolo si fosse fatto
sentire. Particolarmente in timore si dovette essere qui a Santa Maria dove gli
obiettivi militari della città erano agglomerati: quali le Caserme, il deposito
del 48°, il comando della milizia e ultimamente anche il comando dell’armata.
Ma, persistente e lineare era
l’idea che i tedeschi avessero agito e non gli anglo-americani. All’una dopo
mezzanotte un’ondata di bombardieri riprese a bombardare la città gettando
terrore, distruzione e morte. Particolarmente colpiti il rione presso San Gerardo
e presso San Michele, poi Santa Maria. Nella nottata furono gettati razzi
luminosi che illuminavano le scene sinistre. Furono colpiti il palazzo Masella,
il 48° fanteria, la prima Italo Balbo. Volarono via per lo spostamento d’aria
le imposte a nord della chiesa di Santa Maria e si infransero tutti i vetri qui
in convento, mentre il Padre (…) uscì fuori e col Padre Basilio e fra Bernardo
più lesti a fuggire presero il largo. Il Padre Superiore (si tratta dello
stesso Frate Mario Brienza ndr) col
Padre Gabriele uscirono dopo alla terza bomba, vicini, mentre Fra Serafino nel
risveglio repentino e violento non riusciva a raccapezzare una scarpa. Rimase
dentro e passò il resto della notte nella chiesa non sapendo dove andare.
Il Padre Superiore e il compagno, usciti
nella piazza dal cancello, mentre bombe cadevano anche nei dintorni, si
gettavano a terra per evitare spostamenti d’aria e poi, voltando per un
viottolo di campagna, visto aperto l’adito al rifugio preparato per il
comandante dell’armata, vi entrarono trovando ivi un sottotenente con una
squadra di soldati. Nella piazza il Padre Gabriele tremante chiese
l’assoluzione. Ma gli si rispose che non era tempo.
Tutti erano allontanati dal
convento. Il Rettore coi pochi fratini, il Padre Basilio con Fra Bernardo e
Donato Sabia, il superiore e il Padre Gabriele. Solo vi era rimasto Fra
Serafino che, nei momenti di trepidazione sotto gli scoppi delle bombe vicine,
non seppe trovare i sandali e non sapendo dove andare rimase in chiesa tutta la
notte.
Nel Ricovero di Scafarelli i
soldati non facevano che fumare rendendo l’aria irrespirabile e il Padre
Gabriele tutto tremante, in ginocchio, incominciò il rosario di 15 poste.
Mentre di fuori giungevano i rumori delle bombe cui rispondeva lo scotimento
del muro.
Verso le quattro era silenzio. I
soldati con il loro ufficiale erano andati via e il Padre Gabriele non sentendosi
sicuro si premurava di correre alla galleria, in cerca di rifugio più sicuro.
Lo si dovette contentare e correre alla galleria, dove si trovò rifugiata buona
parte della popolazione e anche ufficiali e soldati della vicina caserma.
I discorsi che si facevano era
questi:
«Da che parte venivano i
bombardamenti? Dagli Angloamericani?». Pareva impossibile se si teneva conto
dell’armistizio. Si pensava ai tedeschi, appunto, che fosse una loro vendetta
proprio per l’armistizio.
In mattinata tutto pareva quiete e
calma. Tutti si uscì fuori dai rifugi pensando che fosse finito tutto.
Danni alla casermetta, bombe in
cortile, danni al palazzo Masella e alla tubatura dell’acqua e all’edificio
scolastico Italo Balbo.
Rientrati in convento si celebrò la
messa, si fece la comunione a tutti. Una messa fu pure celebrata alla colonia.
Intanto si sparsero le notizie che
era stata colpita la Cattedrale, l’episcopio e la chiesa di San Michele. Don
Antonio Enrichetti che se l’era vista brutta perché la sua casa fu violentemente
scossa dalle vicine bombe che si abbattevano nel rione Addone, venne giù in
condizioni di eccitamento e mezzo scinto. Raccontò qualche cosa dello stato
delle cose di su, e anche inquilini del palazzo Masella, i cui quartieri non
vennero direttamente colpiti, vennero da noi a riprender fiato.
Il Superiore si recò a San Michele.
I religiosi si erano allontanati. Uno spezzone della piazzetta San Michele,
presso la fontana, aveva con lo scotimento di aria fatto volar via le imposte
della sagrestia, sovrasacrestia e chiesa.
[1]
Su questo periodo è molto utile questa lettura: E. A. Rossi, Una
nazione allo sbando:l'armistizio italiano del settembre 1943 e le sue
conseguenze, Bologna, Il
Mulino, 2003.
[2]
B. Fenoglio, Primavera di Bellezza, Milano,
Grazanti, 1959.
[3]
A. Pellettieri-A. Rubino, Tra il Casale e
la città. Santa Maria del Sepolcro e la vicenda dei Frati Minori in Basilicata,
Foggia, Centro Grafico, 2014.
[4] M. Brienza, Un riflesso della battaglia di Vienna nel
1683 nella processione dei turchi in Potenza, Potenza, 1955.
Una raccolta di foto d'epoca sul bombardamento di Potenza dell'8 settembre 1943 lo trovi qui:


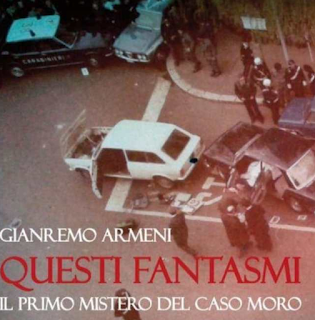
Commenti
Posta un commento